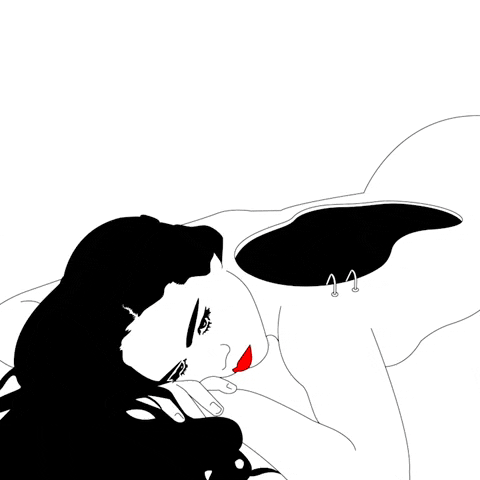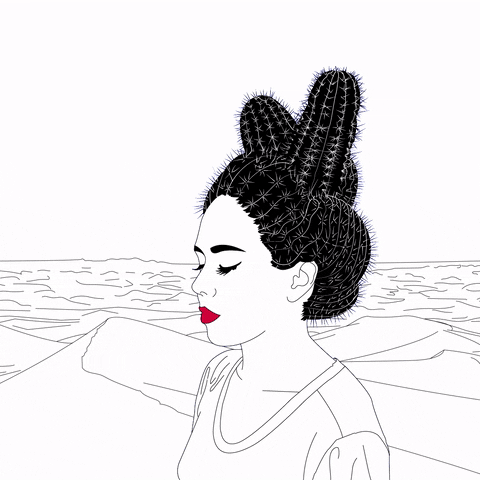Sono nata nel 1994.
Anno della morte di Massimo Troisi, del suicidio di Kurt Cobain, della scesa in campo di Silvio Berlusconi.
In vita mia le guerre le ho viste solo da lontano, senza che mi toccassero davvero. Le rivoluzioni, anche. Ho conosciuto la crisi economica, la crisi dei valori, il crollo delle élite, l'allungamento della speranza di vita, i progressi della scienza, il complottismo e il populismo. Ma la guerra no. Ho sentito i racconti della guerra, i racconti di mia nonna, di bombe e solidarietà, povertà e coraggio, vita e morte. I libri di storia mi hanno aiutato a capire il mondo per come lo vedo oggi, ma niente, nessun libro, nessuna biografia, mi ha aiutato ad affrontare quello che viviamo in questo momento.
Lo stato tutela il bene comune, difende la salute pubblica, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana si sono applicate delle limitazioni così grandi. Siamo in quarantena, tutti. Divisi per nuclei familiari, obbligati all'isolamento, per difenderci da un nemico invisibile. Roba da film fantascientifico da seconda serata. Eppure è la realtà. Denunce per chi non rispetta le restrizioni, supermercati svuotati, esercizi commerciali chiusi.
D'improvviso, ci troviamo con noi stessi, nella solitudine e nella lentezza delle cose davvero essenziali. Sospeso il ritmo di lavoro innaturale, sospese le distrazioni.
E guardiamo il mondo dalla finestra delle nostre case, come da bambini. I palazzi di fronte sono le vele di una grande nave, e noi ci navighiamo sopra. Come diceva Lucio. Si muove la città. Anche se è vuota. Case come alveari ci tengono dentro, siamo il miele.
Make the ordinary, extraordinary.
venerdì 13 marzo 2020
mercoledì 4 marzo 2020
Il virus dentro e fuori
Ho la testa che scoppia.
I telegiornali, le testate sul web, i post facebook dei miei contatti. Ovunque si parla di un virus, il covid-19.
E tu che mi leggi, sì anche tu, sai benissimo di cosa sto parlando.
Da poco è il 2020.
Il nuovo decennio ci ha fatto raccogliere molto dell'odio e della distruzione che abbiamo sepolto, più che seminato, negli ultimi cento anni. Ma aldilà dell'emergenza climatica, dei conflitti mondiali, dell'economia, adesso fronteggiamo un pericolo che non immaginavamo di correre.
No, perché ci siamo abituati al progresso, fino a darlo per scontato e, come per tutte le cose scontate, sminuirlo. Così siamo diventati complottisti, no vax, vegani, medici della prima ora se la connessione internet lo permette. Ecco, oggi è successo che, all'improvviso, quella scienza che tanto ci ha abituato ad avere soluzioni, non sa da dove cominciare.
Non parlerò di contagiosità o morbilità del virus, non mi compete. Parlerò dell'aspetto che ha spaventato di più i virologi e gli epidemiologi di tutto il mondo: l'ignoranza. Quello che ha impaurito tutto il mondo scientifico è stato il non avere soluzioni a un rischio, forse non mortale quanto altri in passato, ma reale. Siamo abituati a strategie di prevenzione, previsione di prognosi, trattamento e terapia in protocolli serrati. Siamo abituati a conoscere cause e conseguenze. Siamo stati educati alla non accettazione del dolore o della morte, giustamente consapevoli dei mezzi che l'umanità si è costruita per sopravvivere. Oggi ci troviamo nudi di fronte a qualcosa che non possiamo controllare del tutto, sopraffatti da noi stessi, dalla parte animalesca, irrazionale, dalla forma di paura più antica di tutte.
Questo è il virus dentro, l'istinto di sopravvivenza, che è il più pericoloso.
domenica 1 aprile 2018
Assenze, dinosauri e cactus.
Come sto?
Tutto bene.
Nel senso che va tutto bene veramente.
No, non preoccuparti.
Tutto normale.
Mi alzo, vado all'università, mi incazzo con Trenitalia, mangio, forse troppo, e dormo, forse poco.
Normale.
Studiare è faticoso, in palestra non mi ci hanno visto mai, c'è Silvio in tv.
Normale.
Quotidiano.
Eppure c'è qualcosa.
Qualcosa.
E' che la birra del venerdì sera non è poi così divertente.
La nostra pizzeria preferita non è niente di speciale.
Il cheesecake fa ingrassare.
Il Wi-fi non prende e il dinosauro non riesce a saltare i cactus.
E non trovo quasi mai parcheggio.
E non è che mi mancano tanto i tuoi occhi, quanto il modo in cui i tuoi occhi vedono le cose.
E c'è che io so benissimo che cosa avresti commentato riguardo alle notizie del TG, ce l'ho in testa il tuo sguardo quando faccio una battuta che non fa ridere.
Però tu non ci sei.
E questa pizza non sa di niente.
Il pistacchio non mi piace più.
La primavera non profuma.
Il nostro film preferito non è più lo stesso.
Però sai che c'è?
C'è che questa tristezza me la voglio godere, perché so che finirà.
Io crescerò, tu tornerai.
E la primavera profumerà di nuovo;
io metterò la panna montata su un gelato cioccolato e fragola;
e torneremo a tuffarci in mare con un 5e5 nella pancia.
E non ci avevo mica fatto caso che quando parlo d'amore, parlo anche di cibo.
Tutto bene.
Nel senso che va tutto bene veramente.
No, non preoccuparti.
Tutto normale.
Mi alzo, vado all'università, mi incazzo con Trenitalia, mangio, forse troppo, e dormo, forse poco.
Normale.
Studiare è faticoso, in palestra non mi ci hanno visto mai, c'è Silvio in tv.
Normale.
Quotidiano.
Eppure c'è qualcosa.
Qualcosa.
E' che la birra del venerdì sera non è poi così divertente.
La nostra pizzeria preferita non è niente di speciale.
Il cheesecake fa ingrassare.
Il Wi-fi non prende e il dinosauro non riesce a saltare i cactus.
E non trovo quasi mai parcheggio.
E non è che mi mancano tanto i tuoi occhi, quanto il modo in cui i tuoi occhi vedono le cose.
E c'è che io so benissimo che cosa avresti commentato riguardo alle notizie del TG, ce l'ho in testa il tuo sguardo quando faccio una battuta che non fa ridere.
Però tu non ci sei.
E questa pizza non sa di niente.
Il pistacchio non mi piace più.
La primavera non profuma.
Il nostro film preferito non è più lo stesso.
Però sai che c'è?
C'è che questa tristezza me la voglio godere, perché so che finirà.
Io crescerò, tu tornerai.
E la primavera profumerà di nuovo;
io metterò la panna montata su un gelato cioccolato e fragola;
e torneremo a tuffarci in mare con un 5e5 nella pancia.
E non ci avevo mica fatto caso che quando parlo d'amore, parlo anche di cibo.
sabato 31 marzo 2018
Totipotenza
A 16 anni ho aperto un blog.
Scrivevo di tutto, con un integralismo ideologico che nemmeno io credevo di possedere.
E mi indignavo di fronte a tante cose.
Cose, che oggi ho imparato ad accettare.
Forse sto esagerando con l'accettazione di ciò che va male.
Di questo passo per i 60 anni voterò centro destra.
Ma questa è un'altra storia.
A 16 anni ho aperto un blog.
Mi piaceva difendere ciò che, nell'ordinario, per me era straordinario.
Non avevo idea di cosa o chi sarei diventata, per la verità non lo so nemmeno adesso e la cosa mi piace.
Tento di difenderla con tutta me stessa questa sensazione di incertezza, mi piace sentirla addosso questa totipotenza da cellula staminale, perché è la cosa più vicina che conosco all'essenza della giovinezza.
Insomma a 16 anni ho aperto un blog, a 16 anni scrivevo e scattavo foto. Mi fa tenerezza rivedere ciò che tentavo di creare e insieme mi rassicura, come mi rassicurava allora, l'idea di aver lasciato tracce di me qua e là.
E la traccia più pura di sé che si possa lasciare sono le idee.
Sarà frutto della mia educazione cattolica, di qualche Don troppo ligio nel trasmetterci la fatuità della vita umana, sarà che sono cresciuta in una famiglia di persone molto più adulte di me, ma ho sempre avuto cucito addosso questo sentimento di precarietà, sin da bambina.
L'ossessione di scomparire prima di aver lasciato qualcosa.
E quindi ecco l'idea del blog, che poi è questo qui, molto ripulito dalla saggezza acquisita negli anni.
Forse diventerà una pagina Facebook.
Oppure no.
Scrivevo di tutto, con un integralismo ideologico che nemmeno io credevo di possedere.
E mi indignavo di fronte a tante cose.
Cose, che oggi ho imparato ad accettare.
Forse sto esagerando con l'accettazione di ciò che va male.
Di questo passo per i 60 anni voterò centro destra.
Ma questa è un'altra storia.
A 16 anni ho aperto un blog.
Mi piaceva difendere ciò che, nell'ordinario, per me era straordinario.
Non avevo idea di cosa o chi sarei diventata, per la verità non lo so nemmeno adesso e la cosa mi piace.
Tento di difenderla con tutta me stessa questa sensazione di incertezza, mi piace sentirla addosso questa totipotenza da cellula staminale, perché è la cosa più vicina che conosco all'essenza della giovinezza.
Insomma a 16 anni ho aperto un blog, a 16 anni scrivevo e scattavo foto. Mi fa tenerezza rivedere ciò che tentavo di creare e insieme mi rassicura, come mi rassicurava allora, l'idea di aver lasciato tracce di me qua e là.
E la traccia più pura di sé che si possa lasciare sono le idee.
Sarà frutto della mia educazione cattolica, di qualche Don troppo ligio nel trasmetterci la fatuità della vita umana, sarà che sono cresciuta in una famiglia di persone molto più adulte di me, ma ho sempre avuto cucito addosso questo sentimento di precarietà, sin da bambina.
L'ossessione di scomparire prima di aver lasciato qualcosa.
E quindi ecco l'idea del blog, che poi è questo qui, molto ripulito dalla saggezza acquisita negli anni.
Forse diventerà una pagina Facebook.
Oppure no.
Monologo sulla felicità.
Ho imparato a pensare alle fortune che ho, prima che alle sfortune.
E che la vita è come la prendi.
Lo stesso vale per la felicità.
Siamo noi che decidiamo se essere felici.
Perché il mondo va a puttane, la maggior parte delle volte, e ti capiterà di svegliarti con il nodo alla gola o di non svegliarti affatto, perché l'ansia non ti ha fatto addormentare.
Che la crisi economica non si cura con la tristezza.
Non è semplice. Affatto.
Io per prima non ci riesco.
Ma intanto l'ho capito.
Poi si vedrà.
E che la vita è come la prendi.
Lo stesso vale per la felicità.
Siamo noi che decidiamo se essere felici.
Perché il mondo va a puttane, la maggior parte delle volte, e ti capiterà di svegliarti con il nodo alla gola o di non svegliarti affatto, perché l'ansia non ti ha fatto addormentare.
Ma in questo secondo, adesso, chiediti:Che se qualcosa andrà male domani, ci andrà lo stesso.
che senso ha non essere felici?
Che la crisi economica non si cura con la tristezza.
Non è semplice. Affatto.
Io per prima non ci riesco.
Ma intanto l'ho capito.
Poi si vedrà.
Domani è Pasqua e Lenticchia non c'è più.
Penso alla differenza sottile fra dormire e morire.
Penso che, da fuori, sembra proprio la stessa cosa.
domenica 23 ottobre 2016
Camici blu
C'è odore di sapone.
Il camice monouso blu, quello dei tirocinanti di chirurgia, è due taglie più grande e mi pizzica.
Ci fanno cambiare in uno spogliatoio stretto e lungo, con gli armadietti su entrambi i lati e un corridoio centrale dove può passare una sola persona per volta.
Un'infermiera ci fa segno di seguirla, che siamo già in ritardo.
I pazienti in sala d'aspetto ci osservano, noi camminiamo veloci per la corsia.
In fila, in silenzio.
In chirurgia non si esce, non si mangia, non si va in bagno.
Una volta entrati nel blocco operatorio, si resta nel blocco operatorio.
Si esce dalla porta quando tutti gli interventi sono conclusi.
Regola numero uno: non ostacolare gli interventi.
Non parlare, non intralciare il passo, non lamentarsi.
Regola numero due: farsi da parte, che siamo l'ultimo anello della catena.
Perché prima ci sono gli strutturati, quindi gli specializzandi, poi vengono i masterizzandi, il blocco infermieristico e, infine, i tirocinanti.
Se ci accorgiamo di star male, porre attenzione al rimettere o allo svenire fuori dalla sala.
Ancora una volta badare a perdere coscienza in un punto che non intralci l'intervento.
Eccoci.
Le parole dell'infermiera sembrano già lontane.
Luci accese, teli verdi.
La mia prima sala operatoria.
Le gambe mi tremano più del solito, ho mal di pancia.
Combatto con le ciocche asimmetriche che scappano fuori dalla cuffia, le spingo dentro.
Accarezzo la porta, l'anta si apre.
Il chirurgo ci accoglie, somiglia a mio padre.
La specializzanda inietta l'anestetico, la paziente agita i piedi, dentro un paio di Converse rosse, numero 37.
Ne ho un paio identico.
La paziente è piccola, tredici anni al massimo, pallida, stringe le mani, l'una contro l'altra, con le dita intrecciate, a darsi coraggio a vicenda.
Forbici, bisturi, leve.
Comincia l'intervento e io mi mantengo in un angolo, guardo le immagini filtrate dalla ripresa di una telecamera e proiettate su uno schermo a parete.
Non voglio guardare.
E se mi facesse impressione?
E se cadessi a terra prima di raggiungere la porta?
Sai che figura di merda.
Poi, passa.
Non so dire precisamente quando.
Non so capirne in perché esatto.
Ma passa.
Passa il mal di stomaco, passano le ansie.
Passano perché guardo la paziente.
Passano perché vedo una ragazzina che fa smorfie di dolore; passano perché vedo una persona che probabilmente ha le mia stessa paura di fare una figuraccia, di mettersi a piangere o di svenire.
Passano perché in quel momento è sola e forse desidererebbe solo gridare, chiudere gli occhi e fingere di essere da un'altra parte, invece è stesa sul lettino, coperta da teli verdi e non ha altro che noi.
Passano perché nella stanza accanto ci sono un paio di genitori preoccupati, che fanno su e giù.
Passano perché c'è qualcuno che ha bisogno di me e non c'è spazio per la paura.
Il camice monouso blu, quello dei tirocinanti di chirurgia, è due taglie più grande e mi pizzica.
Ci fanno cambiare in uno spogliatoio stretto e lungo, con gli armadietti su entrambi i lati e un corridoio centrale dove può passare una sola persona per volta.
Un'infermiera ci fa segno di seguirla, che siamo già in ritardo.
I pazienti in sala d'aspetto ci osservano, noi camminiamo veloci per la corsia.
In fila, in silenzio.
In chirurgia non si esce, non si mangia, non si va in bagno.
Una volta entrati nel blocco operatorio, si resta nel blocco operatorio.
Si esce dalla porta quando tutti gli interventi sono conclusi.
Regola numero uno: non ostacolare gli interventi.
Non parlare, non intralciare il passo, non lamentarsi.
Regola numero due: farsi da parte, che siamo l'ultimo anello della catena.
Perché prima ci sono gli strutturati, quindi gli specializzandi, poi vengono i masterizzandi, il blocco infermieristico e, infine, i tirocinanti.
Se ci accorgiamo di star male, porre attenzione al rimettere o allo svenire fuori dalla sala.
Ancora una volta badare a perdere coscienza in un punto che non intralci l'intervento.
Eccoci.
Le parole dell'infermiera sembrano già lontane.
Luci accese, teli verdi.
La mia prima sala operatoria.
Combatto con le ciocche asimmetriche che scappano fuori dalla cuffia, le spingo dentro.
Accarezzo la porta, l'anta si apre.
Il chirurgo ci accoglie, somiglia a mio padre.
La specializzanda inietta l'anestetico, la paziente agita i piedi, dentro un paio di Converse rosse, numero 37.
Ne ho un paio identico.
La paziente è piccola, tredici anni al massimo, pallida, stringe le mani, l'una contro l'altra, con le dita intrecciate, a darsi coraggio a vicenda.
Forbici, bisturi, leve.
Comincia l'intervento e io mi mantengo in un angolo, guardo le immagini filtrate dalla ripresa di una telecamera e proiettate su uno schermo a parete.
Non voglio guardare.
E se mi facesse impressione?
E se cadessi a terra prima di raggiungere la porta?
Sai che figura di merda.
Poi, passa.
Non so dire precisamente quando.
Non so capirne in perché esatto.
Ma passa.
Passa il mal di stomaco, passano le ansie.
Passano perché guardo la paziente.
Passano perché vedo una ragazzina che fa smorfie di dolore; passano perché vedo una persona che probabilmente ha le mia stessa paura di fare una figuraccia, di mettersi a piangere o di svenire.
Passano perché in quel momento è sola e forse desidererebbe solo gridare, chiudere gli occhi e fingere di essere da un'altra parte, invece è stesa sul lettino, coperta da teli verdi e non ha altro che noi.
Passano perché nella stanza accanto ci sono un paio di genitori preoccupati, che fanno su e giù.
Passano perché c'è qualcuno che ha bisogno di me e non c'è spazio per la paura.
domenica 9 ottobre 2016
Café Society e l'eterno eco della nostalgia
New York, anni Trenta.
Un giovane Bobby Dorfan lascia l'attività del padre per trasferirsi ad Hollywood, California, in cerca di un impiego presso l'ufficio dello zio.
Presto, Bobby, si ritrova solo nell'ambiente snob di Beverly Hills, fino a quando la conoscenza di Vonny, segretaria ed amante dello zio, stravolgerà la sua vita.
Una commedia brillante, frizzante, intrisa di storia e leggerezza.
E' impossibile non innamorarsi di ambientazioni e costumi, del jazz e dello scotch, del fascino e del mistero dell'alta società Newyorkese degli anni Trenta.
Sembra che Woody Allen si sia abbandonato a una dichiarazione d'amore totale verso un'epoca, la sua età dell'oro (come aveva avuto modo di definirla nel film "Midnight in Paris" ndr), in cui Allen si immerge; quell'epoca in cui avrebbe voluto vivere e verso la quale prova un senso di malinconia unico, perché diretto verso un tempo in cui non ha mai vissuto davvero.
E Allen ci riesce.
Perché dalla poltroncina di un cinema sei trasportato sul divanetto in pelle zebrata del locale più in di Manhattan, il Café Society, a sorseggiare Champagne, mentre la voce del narratore scivola, come di velluto, e accompagna un background di storie, di vite, che si alternano veloci attorno al bancone di un bar, al suono del jazz.
L'atmosfera è ovattata, sempre elegante, e ricorda il cinema di quel periodo, fatto di grandi dive e silenzi.
Gli ambienti sono fumosi, le emozioni non lasciano mai spazio al pathos estremo, si gioca sul significato di leggerezza, sorretto da una ironia velata, sempre intelligente.

E' l'eterno eco, l'amplificazione, di un'inettitudine ad amare e ad essere amati, che è una costante di Allen.
Ma l'impossibilità di possedere ciò che si desidera, diventa quasi un'opportunità, che lascia al protagonista il privilegio della dimensione del sogno.
In altre parole, ancora una volta, dona il privilegio della malinconia.

Iscriviti a:
Post (Atom)